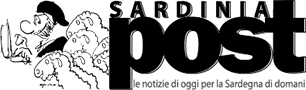di ANDREA TRAMONTE
“Tutto ciò che leggerete è inventato, non è mai successo”, scrive Flavio Soriga all’inizio del nuovo romanzo. Lo scrittore mette le mani avanti con un incipit metaletterario che serve a confondere un po’ le acque e a depistare il lettore, ma così facendo pone inevitabilmente l’accento su quel (presunto) contenuto di verità. Se tu dici “Non pensare all’elefante”, il tuo interlocutore all’elefante ci pensa eccome, spiega il linguista e scienziato cognitivo George Lakoff: la negazione rinforza ciò che stai negando. Soriga probabilmente ne è consapevole. Del resto scrive: “Lo scrittore, dopo tanto penare in solitudine per inventarle, vorrebbe anche che fossero credute tutte vere, quelle storie. Non è possibile che non sia andata esattamente così, sogna l’autore che i suoi lettori pensino”. Il romanzo gioca con questa ambiguità. I riferimenti alla vita di Soriga sono numerosi e a volte si è portati a chiamare il protagonista Aurelio Cossu col nome dell’autore. Che come lui viene da Uta, ha 44 anni, è talassemico, ha una compagna e una figlia piccola e lavora in Rai come autore per programmi culturali. Poi ci sono molte cose che non corrispondono alla realtà. Aurelio non ha mai scritto un romanzo in vita sua, per esempio; la compagna prova a convincerlo a mollare tutto e a dedicarsi alla scrittura di un libro – che avrebbe anche già un titolo, Sardegna cuore nero -, ma lui è dubbioso, nicchia: “Ma cosa vuoi che scriva? dico, Che non ne so, di storie, che non ho pazienza di stare seduto per più di mezz’ora mai, che ho sempre fretta di fare, di andare, che non riesco nemmeno a finire di leggerle, le storie”. E poi ci sono diverse altre cose che immaginiamo non siano mai successe. Ma alla fine siamo sicuri che conti davvero qualcosa distinguere tra autobiografia, finzione e mix di entrambe?
‘Nelle mie vene’ (Bompiani, 288 pagine) segna il ritorno di Soriga al romanzo dopo sei anni dall’uscita del libro precedente. Lo scrittore nel frattempo non è rimasto fermo. È diventato padre e ha lavorato in Rai, soprattutto, e questi due elementi – la paternità e le esperienze nella televisione pubblica – si riflettono sui contenuti del nuovo romanzo. Aurelio Cossu è un precario che collabora come autore a un programma culturale della Rai, Ginseng, durante il quale alcune classi delle scuole superiori gareggiano rispondendo alle domande della conduttrice – che è GeppiCucciari ma non lo è – sull’universo libro. Per via degli ascolti non particolarmente brillanti la direzione della rete decide di cancellare la trasmissione e Cossu si trova di fronte a uno dei tanti bivi che ha dovuto affrontare nel corso degli anni. “Sto pensando che devo pagarmi la vita, devo di nuovo inventarmi qualcosa”, dice, esprimendo una condizione comune a tanti, in questa generazione: dover riniziare sempre da capo, senza alcuna stabilità, senza poter progettare la propria vita nel lungo periodo – e a volte nemmeno nel breve. “Mi sono dedicato a molti lavori e professioni nella mia vita e più o meno mi mantengo da sempre, anche se ho sempre l’ansia, densa malefica ansia, di cadere in povertà, di non riuscire a tirare avanti”.
Una sua amica riesce a procurargli un colloquio per un lavoro con Maria De Filippi: la conduttrice sta preparando un nuovo format all’interno del quale scrittori e scrittrici verranno presentati come delle star, “come fossero calciatori o, cosa ne so? dei cuochi famosi”, e magari dove invitare Bianca Pitzorno, la celebre scrittrice sassarese autrice di libri per bambini, e farle cantare in studio una canzone di Giuni Russo. Aurelio non è esattamente convinto (“Io sospiro. Bianca Pitzorno che canta, in diretta, dico”), ma ha bisogno di soldi e non è sicuro della strada da prendere. Le ansie e i dubbi di un precario del lavoro culturale – un esponente della ‘classe disagiata’, direbbe Raffaele Alberto Ventura – fanno il paio con la sua irrequietezza esistenziale. Aurelio fugge dall’Isola alla ricerca di orizzonti più ampi. Prova una inquietudine “per la limitatezza” della sua vita, uno stato d’animo che sente a Uta prima e poi a Cagliari; combatte costantemente con il bisogno di fuggire “in città e luoghi di cui ignoravo non solo la logica e la geografia, ma persino i nomi”. “Paesano di un paese non lontano dalla città ma pur sempre paese”, dice comunque di sé, e questa percezione è anche una consapevolezza che sembra raggiungere negli anni della maturità, “Non siamo di nessun posto, amica mia, le dico, Tranne forse delle quattro strade in cui siamo nati e cresciuti”.
La struttura procede per scatti indietro e in avanti, mischiando i fatti del presente a una serie di ricordi che sembrano seguire la casualità del flusso dei pensieri del protagonista e non una linearità cronologica (“Per me l’andamento della mia vita risulta, nella mia testa, come una confusa avanzata senza sosta”, dice Aurelio/Flavio). Ci sono ricordi d’infanzia a Uta e della prima giovinezza a Cagliari, il paese e la scuola, il senso di inadeguatezza adolescenziale e le prime esperienze giornalistiche in una combattiva radio cittadina, le scorribande nella provincia campidanese con lo zio e padrino Efisio Carta, il cugino Alessandro e Poldo, a giocare a biliardino (e non solo), e poi i ricordi legati alla talassemia (“Ho quarantaquattro anni e sarei dovuto morire quando ne avevo una decina”). Poi c’è il disincanto verso il mondo dell’editoria e della letteratura, che magari c’entra qualcosa con la lunga assenza di Soriga dalle librerie con qualcosa di nuovo, o magari no. “Il peggio del peggio – fa dire a Peresson, ex cantautore di Decimomannu ora socio di un caffè libreria a San Lorenzo a Roma – è che è pieno addirittura di donne e uomini convinti che i libri siano nientemeno che opere d’arte, incredibilmente ancora c’è chi crede a questa cosa, e soprattutto tra chi ha scritto un libro”. In questo senso Soriga riesce a creare una specie di cortocircuito tra due mondi che frequenta e conosce, quello della tv e quello letterario: immaginare un format dove l’affermazione di uno scrittore passa per il teatrino umiliante di performance vagamente trash sembra un mettere il dito nella piaga delle vanità degli scrittori e una rivalsa verso chi storce il naso di fronte all’idea che un autore possa compromettersi con la televisione, e specie con quella (nazional)popolare.
Uno dei nuclei principali del libro – oltre a quelli, ambiziosi, della tv come spunto per raccontare l’Italia contemporanea e del tema della precarietà lavorativa ed esistenziale – è quello dell’idea del ritorno a casa e del rapporto con le proprie origini. Dopo anni di fughe e di irrequietezza, dopo aver rincorso l’idea di affermarsi nel lavoro o quantomeno di raggiungere una tranquillità economica meno aleatoria, il protagonista sembra scegliere, alla fine, il calore del rifugio familiare e del ritorno a casa. Del resto lo si intuisce, questo senso del ritorno, quando parla della madre che da anni raccoglie informazioni sulle vicende familiari degli abitanti di Uta per scrivere un libro sulla storia del paese, la storia di una comunità. “Mi dispiace nel profondo, questo essermi sradicato”, pensa Aurelio, “questo mio aver sfilato un anello da tutti gli altri, e spero quindi che invece mia madre un giorno finisca questo suo libro, perché ogni comunità ha bisogno di una storia per preservarsi, per raccontare a chi verrà quel che è stato, anche se la storia non insegna alla fine granché, poiché nessuno sa imparare davvero dal passato, ma questo solo possiamo fare: provare a ricordare, perché nessuno abbia donato il sangue invano, perché nessuna generosità sia stata vana, perché ogni vita sia servita a qualcosa”.