
Franco Carta
di ANNALISA ATZENI
Franco Carta E ultimo libro “Su paperi de s’ammentu”, “La carta del ricordo”. Da qui inizia il viaggio alla scoperta del Poeta Franco Carta. “Carta & carta” giocare con le parole che rimangono indelebili nel cuore e nel foglio di carta, inchiostro eterno.
Come è iniziata la tua passione per la poesia?
Salve a te ed ai lettori di Tottus in pari. Ti ringrazio per questa opportunità, dunque iniziamo! Sono nato a Cagliari ma nell’infanzia ho vissuto a lungo in Barbagia dove ho imparato, grazie a mia nonna, ad amare la poesia logudorese. Mia nonna componeva continuamente poesie in sardo, me le recitava (purtroppo non le ha mai trascritte). A 16 anni cominciai a scrivere anche io le prime poesie in sardo che sono rimaste a lungo tempo in un cassetto. Questa passione per la poesia è stata alimentata poi dalla lettura dei poeti italiani del primo novecento, durante il periodo del liceo divoravo poesie. La poesia è vita e la vita ha bisogno di poesia. Tutti abbiamo bisogno di avere attenzioni e le parole sono fondamentali al pari degli abbracci, dei baci e delle carezze. Tuttavia, come afferma Guido Oldani, noi con la nostra modernità fatta di oggetti e tecnologia ci siamo via via allontanati dal piacere della lettura, soprattutto dalla lettura dei versi. Perché la poesia non intrattiene come un romanzo e non insegna come un saggio. La poesia (quella buona) fa pensare e il piacere che ti dà (quando te lo dà) è un piacere raffinato, mentale. Il romanzo, nella sua forma moderna, è il prodotto delle rivoluzioni borghesi: la cultura della borghesia si è fin dall’inizio rispecchiata nel romanzo. La poesia è altro. Appartiene a un’altra dimensione, aristocratica e atemporale. Si è perso il gusto di leggere la poesia. Eppure rappresenta le nostre radici, essendo nata, non solo prima della prosa, ma molto prima della stessa scrittura. Ecco la tradizione orale della poesia fa parte delle tradizioni culturali della mia terra e io amo declamare le poesie in pubblico dove gli spettatori entrano più facilmente nell’universo delle emozioni del poeta.
Quanto è importante per te la tua famiglia d’origine?
La famiglia è la mia identità, le mie radici la mia sardità. e tutto ciò si ripercuote sulla mia poetica, nato da madre cagliaritana e da padre orgolese mi sento intimamente legato ad entrambi i territori e alla loro lingua, infatti scrivo sia in italiano, che in sardu logudoresu e casteddaiu. L’identità e le radici spesso vanno a coincidere, altre volte cerchiamo l’identità e ci perdiamo in un mondo di tenebre come avvenne nel periodo particolarissimo della pandemia. In questo primo ventennio di secolo ho affrontato temi metafisici sperimentando anche il sardo con queste tematiche, una nuova frontiera per la nostra “Limba” e la nostra poetica.
Qual è stata l’influenza di tua nonna sulla tua carriera poetica?
La mia passione per la poesia è nata nell’infanzia trascorsa a Orgosolo dai tre fino ai nove anni in casa di mia nonna (mannai in orgolese), una donna con la dote delle rime che sfoggiava in ogni momento parlando in sardo, lei aveva un ruolo fondamentale in paese: era un’Attittadora. Attittadora è un termine che deriva da attittu, che in origine è il cantidu che la madre destina al piccolo per intrattenerlo e farlo mangiare, usato nell’allattamento. La somiglianza della gestualità del rito di allattamento a quello di veglia del morto non sta infatti nell’aspetto puramente prostrale, ma si arricchisce di una serie di contenuti umani e culturali, i quali conferiscono a s’attittu un significato universale. È l’amore espresso tramite una serie di lamentazioni in versi, spesso cantati, che hanno il valore del dolore e rimettono a Dio l’esclusività nell’istruire la morte. Era questo, infatti, il vero significato de s’attittu, accompagnare e affidare, tramite il canto di una madre, il figlio a Dio. Per la visione istranza invece, il dolore in s’attittu è una proiezione collaterale che inquina un’immagine d’amore facendola somigliare a uno puro strazio umano, in cui la lamentazione è una litania delirante, priva di ogni contenuto culturale. Nell’ottica locale s’attittu è “la piet”, l’omaggio reso dalla Vergine Maria a suo figlio Gesù Cristo. Niente ci nega di pensare che la Madonna accompagnasse le sue lacrime a dei versi d’amore per il suo figlio morto in croce. La prima poesia la scrissi a 17 anni alla morte di mia nonna. È una poesia in sardo logudorese e si intitola “s’Attittadora” è una poesia assolutamente autobiografica perché parla dell’attittu che mia nonna cantò a mio padre morto all’età di 44 anni.
Come sei arrivato a far parte del Cortocircuito Poetico?
Cortocircuito Poetico è il titolo della mia raccolta di poesie in italiano pubblicata nel 2024 il titolo gioca su due significati: il primo legato al mio amore per la poesia ermetica di Montale, Ungaretti e Quasimodo e il mio sperimentare la poesia “corta” nel 2021 attraverso il contatto col poeta cagliaritano Alberto Manca presidente di giuria di un concorso poetico in cui arrivai secondo, dopo la premiazione ebbi un colloquio con lui il quale mi confessò che la mia poesia fosse la sua preferita, ma non la fece vincere perché avrebbe voluto che facessi un esperimento: avrei dovuto rileggerla provando ad eliminare parole o addirittura versi senza modificare il senso e l’emozione dell’opera. Effettivamente quando feci questo lavoro produssi una poesia più bella della precedente e da allora ho adottato questo metodo con le mie opere sia in prosa che in poesia. Il secondo significato è legato alla presenza nel libro di tre diverse sillogi con temi e stili che sembrano cortocircuitare tra loro ma che in realtà non provocano un blackout, ma un’evoluzione.
Qual è il significato del tuo libro “La carta del ricordo”?
Questo libro come è “un’arvèschida” (come dice una mia poesia all’interno) un’alba nuova che può regalare la luce a questa terra antica, e a coloro che volessero imparare il sardo o lo volessero rinfrescare, migliorare o, meglio ancora che volessero imparare la scrittura. È questa la morale della fiaba che apre il libro “Su puzòne iscrittore” dove l’uccello scriba conserva la carta con tutte le storie della tradizione nella zucca della memoria infinita.
Quali temi principali esplori nelle tue poesie?
La poesia vive di emozioni e i temi che affronto sono: i sentimenti, la natura, le mie radici, la storia, i misteri e quindi la sfera metafisica, ma anche la modernità ovvero la scienza e la tecnica, ovviamente come la musica anche la poesia affronta questi temi non in maniera descrittiva (come nella prosa) ma con frequente uso di metafore ed allegorie

Come descrivi il tuo percorso poetico dagli inizi fino ai giorni nostri?
Come ti ho già anticipato il mio esordio nella produzione poetica è stata in limba Logudoresa, il primo libretto di poesie autoprodotto in cartoleria e mai pubblicato si intitolava “Poesia orgolese”, poi qualche anno dopo sotto l’influenza di poeti come: D’annunzio, Ungaretti, Montale e Quasimodo iniziai a scrivere poesie in italiano fondamentalmente con uno stile ermetico asciutto: queste poesie rappresentano una singolare mescolanza di passione ed emozioni, di sentimento e sensualità con versi essenziali e metafore non criptate ovvero molto semplici, ma iniziai a condividere le mie opere solo dopo il 2019 con il primo lockdown partecipando a blog poetici ed a concorsi online in uno dei quali vinsi il primo premio Nazionale “Concorso poesia web COVID 19” con la poesia “Locdaun” una cortissima lirica ermetica in casteddaiu, attraverso il quale ho avuto modo di conoscere Francesco Billeci presidente del concorso e editore indipendente noeap con cui ad ottobre del 2021 pubblicai il mio primo libro in vernacolo (Liriche dalle isole) e due mesi dopo “Versi di Sardegna AAVV” con mie poesie in italiano e in sardo (nelle due varianti). Il risolversi della pandemia con il pericolo superato e la riconquistata libertà, fu per me spunto di riflessione sul significato della vita e del fine vita. Quesiti sulle interazioni tra realtà terrena e ultraterrena diventano ora protagonisti della mia poetica. La Poesia Metafisica nasce dal contrasto tra razionalità e irrazionalità: per quanto l’uomo tenti di ricercare il varco che unisce il mondo fisico al metafisico ‒ che va oltre ‒ è impossibile oltrepassarlo; l’essenza rimane un qualcosa di ineffabile ed irraggiungibile, ed ottiene questo scopo attraverso numerose caratteristiche formali e di contenuto, per mezzo di assonanze, allitterazioni o rime, attraverso inversioni sintattiche, omissioni o ripetizioni, infine per mezzo di metafore, simboli o allegorie. Questa poesia affronta i temi dell’umanità con approccio filosofico e inevitabilmente nel cercare queste risposte si prova turbamento, insicurezza, ma sottrarsi a questa ricerca è tossico perché gli abissi vanno affrontati pur con le vertigini per sconfiggere l’apatia del materialismo, del consumismo, con l’autonomia del pensiero assoluto. Il pensiero metafisico tuttavia si coniuga con l’impegno sociale che la poesia non deve trascurare, ecco quindi la metafora della frusta che simboleggia questo impegno. Dopo il 2023 la mia poetica è fortemente ispirata al manifesto del “Realismo Terminale” che fu presentato nel convegno svolto a Cagliari del 2012, dove si afferma che “il genere umano si sta ammassando in immense megalopoli, le “città continue” di calviniana memoria, contenitori post-umani, senza storia e senza volto. La natura è stata messa ai margini, inghiottita o addomesticata, sono cambiati i nostri codici di riferimento, i parametri per la conoscenza del reale. In passato la pietra di paragone era, di norma, la natura, per cui si diceva: «ha gli occhi azzurri come il mare», «è forte come un toro», «corre come una lepre». Ora, invece, i modelli sono gli oggetti, onde «ha gli occhi di porcellana», «è forte come una ruspa scavatrice», «corre come una Ferrari». Il conio relativo è quello della “similitudine rovesciata”, mediante la quale il mondo può essere ridetto completamente daccapo. In contrapposizione con la similitudine naturale ed è quella che è appartenuta all’uomo e alla poesia dalla notte dei tempi. In essa, il termine di paragone è posto traendolo dall’ambito della natura. L’esempio classico, per quanto banale, è “hai gli occhi azzurri come un cielo d’estate”. La “similitudine rovesciata” è l’utensile per eccellenza del “realismo terminale”; il registro, la chiave di volta, è l’ironia. Ridiamo sull’orlo dell’abisso, non senza una residua speranza: che l’uomo, deriso, si ravveda. Vogliamo che, a forza di essere messo e tenuto a testa in giù, un po’ di sangue gli torni a irrorare il cervello. Perché la mente non sia solo una playstation.
Quali sono le tue influenze letterarie e poetiche?
Ovviamente tutti i classici, ma gli autori che amo visceralmente sin dall’adolescenza e che continuo a leggere e studiare sono: Ugo Foscolo, Gabriele D’Annunzio, Giuseppe Ungaretti, e Edgar Allan Poe, infine, come precedentemente accennato mi sono avvicinato di recente alla corrente letteraria del “Realismo terminale” fondata da Guido Oldani.
Il tuo pseudonimo “Poeta Ibrido” perché l’hai scelto?
Una poesia logudorese pubblicata in “Liriche dalle isole” conteneva per errore il vocabolo bagadìa (nubile) nella variante cagliaritana del sardo al posto della parola corrispondente soltèra in logudorese. Mi accorsi dell’errore dopo l’uscita del libro, decisi di non correggerlo e pensando di aver ibridato la poesia adottai come pseudonimo “Poeta ibrido” che in effetti simboleggia il mio sentirmi italiano, orgolese e cagliaritano nello stesso tempo.
Quali sono le tue pubblicazioni più importanti fino ad oggi?
Liriche dalle isole (Edizioni Billeci); Versi di Sardegna (Tomarchio editore); Versi di Sardegna seconda edizione (Tomarchio editore); Versi di Sardegna terza edizione (DrawUp edizioni); Verso la luce tra identità e radici (LFA Publisher); Dea Madre Terra verso il cambiamento (LFA Publisher); L’Àtropo e i falsi idoli (CTL Editore Livorno); Cortocircuito poetico (DrawUp edizioni)
Quanto è importante la poesia nella tua vita quotidiana e nel tuo lavoro?
La poesia rappresenta la mia anima, e si esprime fondamentalmente nei momenti in cui la mente riesce a vagare dai problemi della quotidianità, o meglio li vede da un’altra prospettiva, Alda Merini scriveva «I poeti lavorano di notte» e condivido questo concetto, perché il silenzio, la solitudine sono il contesto ideale per esprimere le proprie sensazioni, le proprie emozioni in versi. Poi però c’è la condivisione e anche questa fase è importante: leggere in pubblico le proprie liriche e ascoltare quelle degli altri autori arricchisce e nutre l’anima del poeta. tutto questo incide nel quotidiano, nel lavoro, diminuendo lo stress.
Qual è l’importanza del cibo nella tua vita e quali ricordi ti porti da bambino delle cose preparate dalla mamma e dalla nonna?
Il cibo rappresenta tanto nella mia vita esso è infatti testimone delle mie radici e anello di congiunzione con i miei figli come se fosse un ponte tra passato e futuro, dalla mia infanzia mi porto i ricordi del cibo orgolese preparato da mia nonna e dalle mie zie e i dolci campidanesi (principalmente le zeppole) preparati da mia madre, ovviamente quando incontro mio figlio che abita a Roma cucino io alla sarda, quando lui viene da me qualche volta cucina lui alla romana, anche questi sono scambi culturali. Ora vi regalo una mia poesia dedicata ai cibi orgolesi mai pubblicata perché scritta in orgolese stretto e in letteratura generalmente si accetta il logudorese e il campidanese, ma non l’ho mai voluta correggere. Ammentos:
Eo m’ammento dae mannai, su pistiddi e s’aranzada, savadas chin zuccaru o mele gai, caffè cun s’ou bin d’aiada; e fintzas s’orilletta, su mele mannoi lu vattìa, in paris a sa frue e su casu ‘e vitta. A mesu die coccone de candelarìa, e pustis Maharrones lados chin bànza ‘e vervehe su ministru piaghida a pahos. E su duminigu pani vrattau anzone puntu a roda, sa purpuzza o su polheddu in tottu sa vidda. In ierru vervehe a buddiu e patata e corronzolu. Ma s’ispuntinu orgolesu in domo fiat sempre pani e casu.
Cosa tramandi dei tuoi ricordi d’ infanzia e qual è la cosa che più ti rappresenta?
Vorrei tramandare l’amore che nutro per la nostra isola e la volontà di riscatto e indipendenza che spesso manca nei nostri conterranei, per questo motivo nelle mie poesie in sardo le tematiche sono proprio queste con amore per le nostre tradizioni e impegno sociale verso tutte le problematiche che colpiscono la nostra terra e che potrete trovare in poesie come: “Seu naschidu in Sardigna” “Fogu” “Infustùra” “Sa badde ‘e su male” e tante altre
Quali sono i tuoi progetti futuri?
Nell’immediato sto curando la pubblicazione dell’Antologia “Versi di Sardegna” quarta edizione, progetto che mi onoro di aver contribuito dalla prima all’ultima edizione e che dovrebbe veder la luce tra qualche mese, per il futuro sto lavorando alla riduzione teatrale di un mio racconto storico (I falsi idoli) tratto da una vicenda sarda accaduta del primo ottocento e poco conosciuta e non smetto comunque di scrivere poesie (Il mio primo amore) Vi saluto con una mia breve poesia d’amore:
Lughe de luna giuchet e in s’ iscur’abbarrat dellíriu in presse brujat filos galanos istramant. Sos amorados non ant etade s’amantìa chi tenent in coro giuchet dae su riu, in solidade finzas a domo issoro.








































































































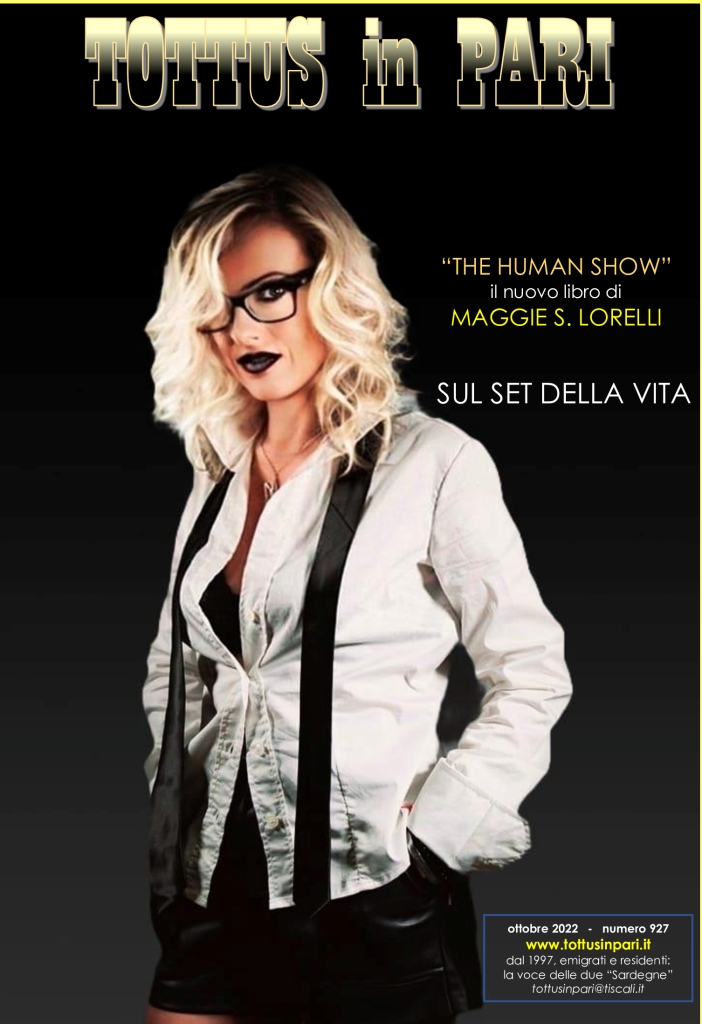
Ringrazio Annalisa Atzeni e la rivista Tottus in PARI per l’intervista in occasione dell’uscita della mia silloge in logudorese “Su papéri de s’ammentu” e ringrazio l’editore no eap Noiqui nella persona di Luciano Zampini Poeta che mi ha permesso di realizzare questo sogno chiuso in un cassetto da due anni
Tanti complimenti Franco 👏
Affettuosi complimenti!
Sei bravo Franco e per questo ti auguro mille di questi libri!❣️
Complimentissimi Franco❤
Complimenti Franco.Bravissimo.
Complimenti
Complimenti Franco👏👏
Complimenti a tutti di ❤️
Congratulazioni
Sei una persona meravigliosa Franco e in poeta bravissimo, è stato un onore per me , grazie di ❤️
Complimenti
Congratulazioni Franco👏👏