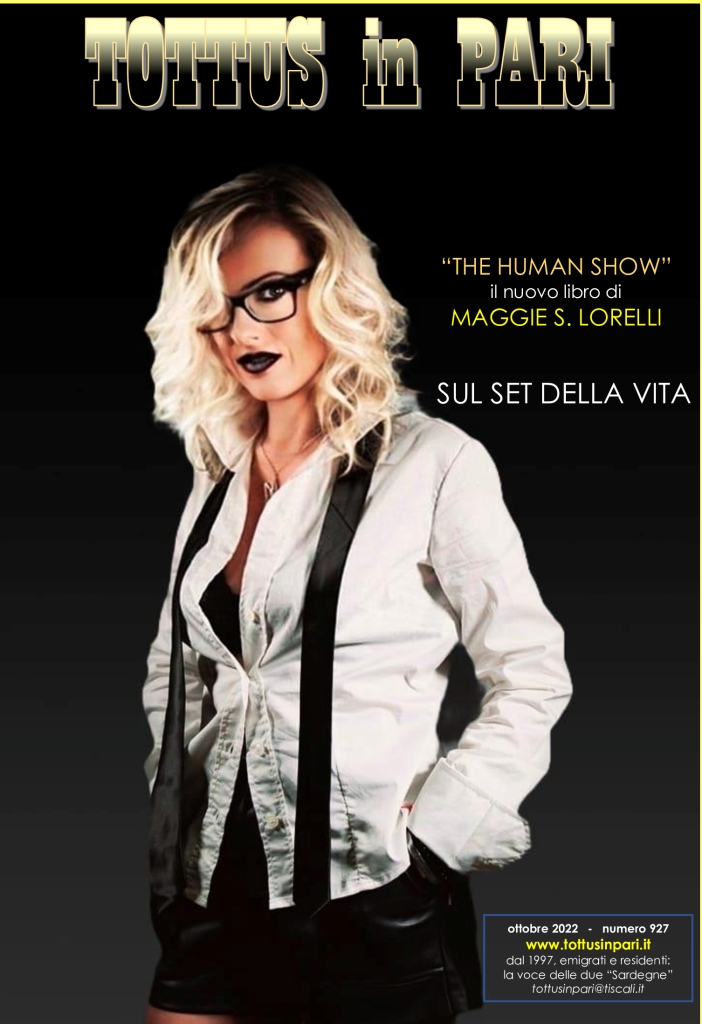a cura di ORNELLA DEMURU
Questa una delle affermazioni di Carlo Felice, ancora solo viceré di Sardegna, in una lettera indirizzata al fratello re Carlo Emanuele IV durante una delle tante repressioni nell’Isola.
Il 19 aprile del 1821 con l’abdicazione dell’altro fratello Vittorio Emanuele I il fratello minore Carlo felice il 25 aprile, assumerà la dignità ed il titolo di re.
La Sardegna recava i segni della grave crisi degli anni 1793-96 durante i quali, al tentativo di sollevazione nazionale e antiassolutistica della “fazione dominante cagliaritana” capeggiata dagli Stamenti, era seguito il tentativo secessionistico, contro la tirannia della capitale, da parte di Sassari, roccaforte della reazione nonché del lealismo monarchico, e poi la violenta ribellione (luglio 1795) dei vassalli e delle plebi derelitte contro le insostenibili angherie feudali.
Nel biennio 1797-98 aveva trionfato la reazione violenta (imperniata peraltro, più che sul potere centrale, sulle iniziative locali e individuali) ma erano rimaste intatte tutte le cause delle agitazioni e delle sedizioni.
Il sovrano e la famiglia reale furono comunque accolti con giubilo dalla popolazione, e fatti segno a manifestazioni di generosità da parte delle classi dominanti. Risultò rinsaldata la fedeltà dinastica, e favorito un certo processo di pacificazione sociale.
Privo non soltanto di esperienza politica ed amministrativa, ma anche di vera attrazione per l’esercizio del governo, C. F. assunse l’incarico come un dovere non derogabile, ma volle esercitarlo come un diritto non delegabile né condizionabile. Sostenuto, per convinzione o per calcolo, dalla feudalità isolana, egli rintuzzò l’autonomia della burocrazia e perfino della magistratura, che volle docili strumenti della sua autorità, e dei collaboratori, che volle umili esecutori della sua volontà, e rivendicò pienezza di potere perfino nei confronti della corte.
Della complessa crisi sarda Carlo Felice mostrò subito di aver colto chiaramente l’aspetto esteriore e formale dell’attentato all’autorità assoluta rappresentato dagli attacchi ai valori e alla ideologia dominante, e dalla minaccia alla stabilità dell’ordine sociale.
Il suo impegno massimo e prioritario fu subito volto a riannodare fermamente nelle sue mani (come farà dopo il ’21) tutte le fila del potere, e a perseguire con implacabile determinazione ogni tentativo di ribellione all’autorità, alle leggi, all’ordine costituito.
Instaurando un vero e proprio regime militare, creò una magistratura speciale, la Vice-Regia Delegazione per l’istruttoria dei processi politici, ed il primo ad essere celebrato fu quello a carico del “capopolo” V. Sulis, colpevole di nient’altro (altre accuse non risultarono provate) che di essersi sostituito all’inetto viceré nel domare la rivolta, mortificando però, così, l’autorità costituita, un reato mai abbastanza punito per C. F., che giudicò “mite” la condanna a vent’anni di carcere.
Nel perseguire i “rei di stato” legittimò l’adozione di procedure militari ed ogni arbitrio di polizia, dallo spionaggio alla censura epistolare e alle taglie sugli indiziati (lettere del 16 e 20 ag. 1800, 23 ott. 1802).
Ossessionato dal pericolo dei giacobini, nel biennnio 1800-1801 scoprì e schiacciò alcune loro macchinazioni. La più grave prese il nome dal frate Gerolamo Podda, che aveva fatto della sua cella la sede di una specie di club giacobino, e che, morto in carcere prima della sentenza, fu processato con una procedura che ancora nel 1807 il Maistre definiva “monstrueuse”.
Nel giugno 1802 ci fu un tentativo rivoluzionario dei fuorusciti sardi in Gallura, preparata alla rivolta dal notaio Cilocco. I ribelli proclamarono la Repubblica sarda, catturarono un bastimento postale e si impadronirono delle torri di Longosardo, Vignola e Isola Rossa.
La repressione spietata accentuò la feroce severità dell’immagine pubblica di C. F., ma – come osservava il Pontieri – fece sorgere la convinzione che nell’isola “spirasse un’aura per nulla benigna alle avventure”.
Da re non rimise piede in Sardegna, che però non trascurò. Peggiorando ancor di più la condizione dei più umili.
Negli anni 1822-1828 fece riprendere i lavori per la grande strada trasversale Cagliari-Porto Torres, poi intitolata al suo nome; corresse con criteri di decentramento la legge sulle prefetture; introdusse le cartelle del credito pubblico; regolamentò la materia delle dogane e del contrabbando.
Con l’editto delle Chiudende, infine, promulgato il 6 ott. 1820, ma pubblicato soltanto il 4 aprile 1823 si propose sulla linea di una tradizione risalente al pensiero del Settecento e più recentemente sostenuta dalla Società agraria, dagli incaricati di funzioni viceregie, da funzionari della segreteria di Stato per gli affari della Sardegna e infine da P. Balbo – di incrementare la proprietà, borghese e la produttività.
Per le resistenze però dei feudatari, dei pastori ed anche dei Consigli comunitativi, l’editto delle Chiudende trovò in quegli anni scarsa applicazione.
Ad una intensificazione seguita ad un viaggio di Carlo Alberto in Sardegna, verso la fine del decennio, corrispose una violenta reazione da parte dei pastori in varie zone dell’isola.
L’impresa più impegnativa fu il Corpo delle leggi civili e criminali del Regno di Sardegna promulgato il 16 genn. 1827.
Morirà dieci anni più tardi, nel 1831.